
Studenti gifted: quali normative, quali sfide educative?
La plusdotazione a scuola
Per un lungo periodo la plusdotazione (o giftedness) è rimasta in una zona d’ombra e non è stata al centro degli interessi del mondo educativo italiano.
I temi centrali erano altri: l’inclusione, i BES, la personalizzazione… e gli studenti ad alto potenziale cognitivo continuavano a non essere visibili e considerati. Troppo capaci e competenti per essere pensati come studenti e studentesse in difficoltà, ma anche troppo diversi per essere capiti davvero.
"La plusdotazione è considerata una condizione neurodivergente e le stime internazionali indicano che riguarda una percentuale della popolazione scolastica che è generalmente compresa tra il 2% e il 5%, a seconda dei criteri utilizzati per la definizione. Si manifesta con un quoziente intellettivo significativamente superiore alla media e coinvolge aspetti emotivi, relazionali, creativi e motivazionali. In Italia, la mancanza di una normativa specifica ha spesso relegato questi studenti ai margini del sistema, con conseguenze negative sul piano dell’apprendimento e del benessere psicologico. Questi sono ragazzi con un quoziente intellettivo superiore alla media, a volte oltre il punteggio di 130, che dimostrano capacità di apprendimento e curiosità intellettuale molto sviluppate rispetto alla loro età e al loro livello di scolarità". (C. Naressi, 2025)
La National Association for Gifted Children (NAGK – UK) definisce i bambini gifted come "[…] persone che mostrano, o hanno il potenziale per mostrare, un livello eccezionale di performance, se confrontati con i loro pari, in una o più delle seguenti aree: abilità intellettiva generale, specifica attitudine scolastica, pensiero creativo, leadership, arti visive e dello spettacolo".
(Manuale operativo: interventi e strategie per l’alto potenziale cognitivo)
La valutazione per plusdotazione rappresenta, però, solo il primo passo di un lungo cammino che ha come fine ultimo quello di raggiungere il pieno benessere ed un equilibrato sviluppo del bambino, dal punto di vista cognitivo, emotivo e sociale a casa e a scuola.
A seguito della valutazione del profilo di funzionamento, viene rilasciata alla famiglia una relazione di sintesi del profilo emerso (con punti di forza e criticità), che i genitori possono portare a scuola. L’incontro tra genitori, dirigente scolastico e insegnanti (con possibile presenza di altri professionisti) è di fondamentale importanza non solo perché la scuola venga informata del profilo emerso, ma anche per formulare le possibili proposte di intervento sulla base delle indicazioni emerse. L’evoluzione dell’allievo e la messa in atto delle strategie didattiche e pedagogiche suggerite (Approfondimenti nel pdf scaricabile - Cosa prevede per i docenti il disegno di legge n. 180 approvato dal Senato il 7 ottobre 2025?) dovrebbe essere valutata periodicamente dai docenti, in stretta collaborazione con la famiglia.
In Italia, per anni, i diritti di questi bambini/ragazzi al successo formativo non sempre sono stati rispettati, mentre nel resto d’Europa questo non è avvenuto. E questo vuoto normativo stupisce ancora di più perché siamo il Paese dove la scuola è l’erede di Maria Montessori e di don Milani, con un percorso di inclusione già tracciato da tempo.
Infatti, in diversi Paesi esteri, a partire da quelli anglosassoni fino agli Stati membri dell’Unione Europea e a quelli asiatici (es. Singapore, Malesia, Cina), per i ragazzi dotati di particolare talento o precocità è prevista una certa flessibilità del percorso scolastico… e/o questi studenti vengono sostenuti attraverso attività extra-scolastiche diverse.
In Italia, invece, spesso sono costretti a seguire i cicli con una certa rigidità.
I salti di classe, ad oggi, possono essere fatti alle primarie (primina) o alla fine delle superiori, con il diploma anticipato al quarto anno. In entrambi i casi, la nostra normativa comprende criteri più legati all’età e alla performance piuttosto che al riconoscimento del talento.
Anche per l’università è possibile laurearsi anticipatamente, secondo un regolamento di ateneo, ma in diversi casi non più di un anno prima. Come fa notare V. Castelli, presidente dell’associazione Step-Net, tuttavia, “non necessariamente il salto di classe è la via più adatta per il ragazzo gifted, anche se a loro parere deve esistere la possibilità, per chi ha necessità, di saltare le classi secondo le proprie esigenze”. (C. Ardizzone, 2017)
Occorre, però, sottolineare che, anche se le modalità per l’inclusione scolastica erano già state definite con la Direttiva Ministeriale dei BES (Bisogni Educativi Speciali) del 27 dicembre 2012, in seguito, con la Nota Ministeriale n. 562 del 3 aprile 2019 si specificava che gli alunni ad alto potenziale intellettivo rientravano nei BES.
Con la Nota Ministeriale n. 562 il Ministero ha così, almeno in parte, colmato il vuoto normativo che non garantiva esplicitamente agli studenti dotati di un alto potenziale intellettivo il diritto a una didattica personalizzata.
"In molti casi però le scuole avevano già provveduto in autonomia a definire un PDP (Piano Didattico Personalizzato) nei casi in cui, come previsto dalla normativa per i BES, era stato riscontrato dai docenti un disagio comportamentale/relazionale e nel caso degli studenti plusdotati può essere utile invece differenziare la didattica per renderla più stimolante e interattiva al fine di favorire il coinvolgimento dei ragazzi nel proprio processo di apprendimento." (Fonte Invalsi Open, 2022)
In ogni caso, la disamina legislativa su questa tematica è stata ripresa nel 2023, quando alcune forze parlamentari hanno raccolto le istanze di famiglie, associazioni e centri di ricerca che chiedevano una normativa specifica.
Il testo è stato approvato in Commissione a fine maggio 2025 e in Senato all’inizio di ottobre 2025, con un ampio consenso trasversale.
Infatti, il 7 ottobre 2025, il Senato ha approvato il disegno di legge n. 180 "Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi", che passerà ora all’esame della Camera. Se la Camera lo approverà senza modifiche, la legge sarà promulgata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. In caso contrario, dovrà tornare al Senato per l'approvazione definitiva.
Un momento importante per questi ragazzi e ragazze, che ha segnato il primo riconoscimento formale della plusdotazione nel nostro ordinamento scolastico.
Il disegno di legge introduce, infatti, per la prima volta in Italia, un quadro normativo specifico per il riconoscimento e l’inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo.
Dall’analisi del testo emergono misure significative pensate per supportare questi studenti:
- riconoscimento ufficiale degli alunni con alto potenziale cognitivo;
- istituzione della figura del referente scolastico per l’APC in ogni istituto;
- formazione obbligatoria per docenti e dirigenti scolastici;
- introduzione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) specifico;
- collaborazione con le famiglie nella definizione degli interventi educativi. (F. Di Palma 2025)
Il nostro Paese si allinea così alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1994 sull’educazione dei bambini ad alto potenziale.
"Con questo provvedimento si compie un passo decisivo verso una scuola capace di valorizzare i diversi talenti dei giovani. Gli alunni ad alto potenziale cognitivo sono una risorsa straordinaria per il Paese, ma troppo spesso non vengono riconosciuti e sostenuti adeguatamente. Con le misure previste dal DDL si afferma un principio fondamentale: nessuno deve esser lasciato indietro, ma allo stesso tempo nessuno deve essere limitato rispetto al proprio potenziale. La personalizzazione della didattica è la chiave per permettere a ogni giovane di esprimersi al meglio. Continuiamo a lavorare per un'istruzione più moderna, che metta al centro la persona dello studente", ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
Ma chi sono gli studenti ad alto potenziale cognitivo?
Per alunno o studente ad alto potenziale cognitivo, chiarisce il testo di legge, si intende "l’alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione, compreso l’alunno o lo studente con doppia o multipla eccezionalità". (Fonte Senato della Repubblica)
Spesso i comportamenti che vediamo negli studenti plusdotati, che non ci permettono di riconoscerli come tali, riflettono proprio il disagio di non riuscire a gestire il contrasto tra ciò che sono e il modo in cui è organizzato l’ambiente, familiare e scolastico, in cui vivono tutti i giorni.
Inoltre, sono bambini e bambine, ragazzi e ragazze molto curiosi, su ciò che è di loro interesse: hanno una velocità di apprendimento, che può essere anche settoriale, inusuale per l'età. La noia è sempre in agguato e a volte appaiono distratti quando seguono quanto viene loro spiegato e possono avere, soprattutto da piccoli, problemi a relazionarsi con i pari perché non trovano argomenti di interesse comune da condividere, soprattutto nei momenti di relazione ludica, come l’intervallo e i momenti di gioco libero. Dimostrano una capacità di comprendere concetti o di svolgere attività complesse molto superiori ai coetanei; pongono mille domande, a cui a volte gli adulti non sanno immediatamente rispondere… e che stupiscono per la precocità.
Gli studenti plusdotati non si accontentano delle risposte che ottengono, hanno competenze più che avanzate in determinati ambiti, utilizzano l'intuito, la logica, il pensiero creativo e laterale per giungere a conclusioni originali, capiscono in profondità le cose, grazie alle capacità intellettive che possiedono, e imparano in maniera estremamente rapida tutto ciò che comprendono.
Allo stesso tempo, però, questa condizione può presentare diverse problematiche, in contesti, soprattutto scolastici, in cui le capacità individuali non sempre vengono valorizzate e accettate. Noia, demotivazione e frustrazione possono perciò subentrare con facilità e trasformarsi anche in comportamenti oppositivi o provocatori, rendendo il percorso scolastico dei bambini plusdotati molto complesso e poco gratificante sia per il docente che per lo studente.
Cercano spesso l'adulto per avere un confronto perché sono in difficoltà quando si tratta di collaborare e lavorare con i pari, con i quali, spesso, non condividono gli stessi interessi e le stesse modalità di apprendimento. Possono, quindi, desiderare una forte relazione con gli adulti, con cui invece riescono a ragionare e discutere mettendosi quasi sul loro stesso piano.
Alcuni sono molto sensibili, sono più fragili di fronte alla non valorizzazione e riconoscimento dei loro talenti, situazione questa che li può portare a chiudersi e isolarsi e spesso la risposta a una simile situazione è quella di uniformarsi agli altri, non coltivando le proprie eccezionali doti. Quindi l'incomprensione, da parte di educatori, insegnanti e coetanei, è dietro l'angolo anche perché, spesso, espongono idee strane e bizzarre, sicuramente non adeguate per l’età.
Spesso si ha l’immagine di loro come studenti di successo, che a scuola ottengono ottimi risultati e voti alti; in realtà nello stesso studente si potrebbero presentare performance diverse relativamente ad alcune competenze scolastiche, particolarmente brillanti, accanto ad altre deficitarie.
(Chi sono i bambini /ragazzi gifted o plusdotati?)
A volte le loro difficoltà ad adattarsi ad un ambiente che spesso non li accetta può portare questi bambini e ragazzi ad adottare comportamenti scorretti o rendimento negativo, fino all’insuccesso scolastico o all’abbandono degli studi. Paradossalmente, possono avere risultati non buoni a scuola, proprio perché non identificati come studenti plusdotati.
In alcuni casi smettono di studiare poiché non ne vedono l’utilità, il loro pensiero va oltre la semplice lezione o spiegazione e passano anni tra i banchi senza affrontare situazioni sfidanti che permettano loro di crescere e misurarsi con difficoltà adatte al loro potenziale, capiscono in fretta che a scuola non hanno bisogno di studiare o fare ciò che l’insegnante chiede per andare bene. Nonostante questo non si percepisca dai voti che ottengono, poiché anche lavorando al minimo riescono comunque sempre a ottenere voti positivi, spesso arrivano alle scuole secondarie senza un metodo di studio. A quel punto, di fronte ai primi insuccessi scolastici, possono sentirsi molto frustrati, perdere di autostima o di fiducia nelle proprie capacità.
È ovvio che questi atteggiamenti non sono sempre presenti in tutti gli studenti plusdotati, ma rappresentano comunque un segnale importante che è fondamentale riconoscere, non solo per riuscire a individuare questi studenti e studentesse, ma anche per poter garantire loro il supporto didattico di cui hanno necessità.
Il percorso scolastico, per gli alunni plusdotati, è, quindi, spesso una strada in salita.
La ricerca ha dimostrato che i bambini e gli adolescenti plusdotati hanno spiccate attitudini per diversi campi del sapere: questa considerazione è una chiave di svolta perché il rischio non è solo che queste potenzialità rischino di non emergere perché non vengono riconosciute, ma perché non vengono stimolate in modo adeguato. Infatti è importante riconoscere queste abilità e competenze il prima possibile per poter corrispondere alle reali esigenze individuali e agire nella didattica quotidiana.
Va anche ricordato che la condizione di plusdotazione non è una caratteristica fissa e immutabile: se non adeguatamente alimentata, si rischia di perdere tutto o gran parte del potenziale con un profondo senso di rinuncia e una riduzione delle abilità e il talento di un bambino/ ragazzo plusdotato da punto di forza può facilmente trasformarsi in peso e debolezza.
La ricerca di un equilibrio, spesso in bilico, tra le risorse di questi studenti e la loro fragilità, soprattutto all'interno di un contesto di classe, è il reale compito dei docenti perché un pensiero o un'idea, che per uno studente plusdotato non è che uno spunto per nuovi sviluppi e nuovi orizzonti, difficilmente vengono capiti da compagni e insegnanti.
È importante che l’ambiente scolastico sia stimolante, rispettoso e motivante: uno studente che si sente apprezzato e accettato, molto probabilmente, vivrà in modo diverso l’esperienza scolastica e metterà energia nel processo di apprendimento. Per questo gli insegnanti devono essere in grado di interpretare i diversi bisogni di tutti i loro allievi e di valorizzarne le caratteristiche peculiari, cioè di personalizzare il processo di insegnamento-apprendimento in ambienti creativi e stimolanti.
Il Disegno di legge prevede un vero e proprio piano di formazione triennale per i docenti.
(Approfondimenti nel pdf scaricabile - Cosa prevede per i docenti il disegno di legge n. 180 approvato dal Senato il 7 ottobre 2025?)
Nasce però un dubbio: la formazione dei docenti può diventare l’anello debole del disegno legislativo?
Riportiamo alcune interessanti riflessioni.
"Il disegno di legge sugli studenti ad alto potenziale cognitivo rappresenta certamente un passo avanti sul piano culturale, ma il suo successo dipenderà interamente da quanto e come verrà formata la scuola che dovrà metterlo in pratica. Infatti Il DDL parla di un “Piano triennale sperimentale di formazione", ma non definisce con chiarezza né le modalità né le risorse economiche necessarie per renderlo operativo. E questo è un punto critico. Senza fondi adeguati e senza percorsi formativi diffusi e continuativi, il rischio concreto è che la "formazione" resti confinata a pochi corsi pilota, magari opzionali, lasciando la maggior parte dei docenti privi di strumenti reali per riconoscere e accompagnare gli studenti plusdotati.
Un’altra debolezza è che il DDL non specifica quale tipo di competenze dovranno acquisire gli insegnanti. La plusdotazione non si manifesta in modo uniforme: può convivere con disturbi dell’apprendimento, difficoltà emotive o comportamentali, e richiede una preparazione pedagogica e psicologica molto raffinata. Se la formazione resterà troppo teorica o standardizzata, non servirà a costruire quella sensibilità necessaria a distinguere tra "alto rendimento scolastico" e "vero potenziale cognitivo".
Inoltre, la mancanza di criteri univoci per l’identificazione degli studenti rischia di rendere la formazione inefficace: ogni scuola o docente potrebbe interpretare la plusdotazione in modo diverso, generando disomogeneità e disparità territoriali. In pratica, si chiede agli insegnanti di riconoscere e valorizzare questi alunni, ma senza fornire parametri chiari o strumenti di valutazione condivisi.
Infine, la delegazione al Governo per i decreti attuativi è un altro punto critico: la formazione dei docenti dipenderà dalle scelte politiche future, e non da una strategia già delineata. Questo potrebbe allungare i tempi e ridurre la coerenza del progetto, allontanandolo dalle reali esigenze del personale scolastico”. (G. Carillo, 2025)
In conclusione, si può affermare che, accanto al lavoro e all’impegno della scuola, è indispensabile la presenza di genitori consapevoli: una risorsa fondamentale per far emergere il potenziale dei bambini e dei ragazzi plusdotati, senza farli sentire diversi o incompresi ed è fondamentale che si crei un rapporto di squadra tra insegnanti e genitori.
Ognuno deve fare la sua parte, in un percorso coordinato, affinché il benessere di questi studenti sia raggiunto attraverso l’accoglimento dei loro reali bisogni e delle loro grandi potenzialità.
La scuola del futuro non sarà quella che insegna le stesse cose a tutti, ma quella che saprà riconoscere e coltivare le differenze e le peculiarità di ciascuno e la didattica inclusiva sarà realizzabile solo se la comunità educante rifletterà sui presupposti che permettono la personalizzazione dell’insegnamento per tutti gli studenti e le studentesse.
(Come accompagnare gli insegnanti nella personalizzazione?)
Attenzione, in un’ottica inclusiva, non riserviamo le attività pensate per loro solo a loro! La programmazione pedagogica e didattica per questi studenti necessita sicuramente di un cambio di prospettiva che, se adottata per tutta la classe, porterebbe dei benefici a tutti gli alunni.
(Approfondimento nel pdf scaricabile - Quali strategie didattiche utilizzare con i gifted?)
BIBLIOGRAFIA
- C. Naressi (2025), Disegno di legge sulla plusdotazione. Inclusione scolastica per gli studenti APC, Scuola 7
- C. Ardizzone (2017), Gifted & talented: i genietti che ci sono ma non si vedono, Skuolanet
- Gli alunni plusdotati e ad alto potenziale nella Scuola (2022), Invalsi Open
- F. Di Palma (2025), Alunni plusdotati, in arrivo una nuova legge: ecco chi dovrà formarsi e cosa cambierà, Tecnica della scuola
- Fonte MIM, Scuola, approvato al Senato il ddl per il riconoscimento degli studenti ad alto potenziale cognitivo
- G. Carillo (2025), Studenti plusdotati: approvato il ddl per riconoscerli e includerli (ma mancano i docenti preparati), Greenme
- Winebrenner S. & Brulles, D. (2012) Teaching Gifted Kids in Today’s Classroom. Strategiesand Techniques Every Teacher Can Use. Minneapolis MN: Free Spirit Publishing.
- Manuale operativo: interventi e strategie per l’alto potenziale cognitivo
- Disegno di legge sugli alunni plusdotati: il commento dell’ANP
- Baldacci M. (2002), Una scuola a misura di alunno. Qualità dell’istruzione e successo formativo, UTET, Torino
A cura di Viviana Rossi e Maria Enrica Bianchi

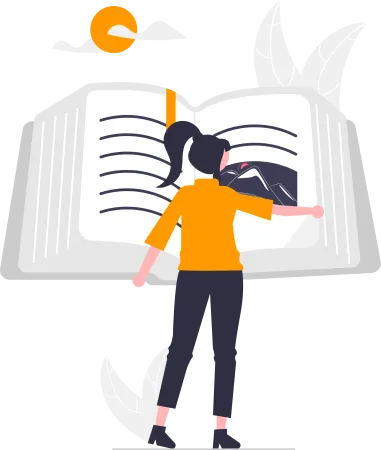

Sei un insegnante?
Scopri la nuova sezione Fai una domanda alle nostre autrici.
Sarà possibile porre alle autrici del blog, Enrica Maria Bianchi e Viviana Rossi, domande di approfondimento sui vari articoli, compilando un semplice form!
Domande e risposte saranno rese pubbliche.
*Per accedere alla sezione usa le tue credenziali Lattes. Se non sei ancora registrato clicca qui!



